|
|
La generazione
d’oggi che nelle
gite e sulle
spiagge si
trastulla con i
miracolosi «
transistor »
noncurante,
assai spesso,
della
tranquillità del
vicino, o che fa
spreco in altro
modo delle
utilitarie «
onde hertziane
», non sempre è
al corrente
dello sforzo
tenace che
occorse a
Guglielmo
Marconi ed ai
suoi
collaboratori
per portare la
radio al suo
prodigioso stato
attuale che ha
dato, fra
l’altro,
all’umanità i
benefici della
televisione e la
possibilità di
portare
l’indagine
scientifica nel
cosmo con la
trasmissione di
dati strumentali
a milioni di
chilometri.
Ma siamo ormai in pochi, nel nostro
magnifico golfo,
a ricordare quei
giorni, ormai
lontani, del
luglio 1897 in
cui il
giovanissimo
inventore
riusciva a
ricevere a bordo
di una nave
della regia
marina, seppure
con qualche
difficoltà, alla
distanza massima
di una ventina
di chilometri, i
segnali Morse
trasmessi da un
impianto
sperimentale del
suo « telegrafo
senza fili »
collocato nel
laboratorio
elettrico della
Marina a San
Bartolomeo. A
distanza di due
anni dalle ormai
famose
esperienze di
Pontecchio
bolognese, la
trasmissione
fuori delle
acque del Tino
fece epoca nel
mondo
scientifico ed
applicativo, per
due ragioni:
primo perché
nelle precedenti
trasmissioni
fatte dal
Marconi in
Inghilterra non
si erano
raggiunte
portate
superiori agli 8
chilometri,
secondo perché
alla Spezia si
tentava per la
prima volta la
ricezione dei
segnali a bordo
di navi, cioè in
ambiente che
vari tecnici non
ritenevano
adatto a
ricevere in modo
efficiente le
onde elettriche,
sul
comportamento
delle quali si
avevano scarse
conoscenze.
Su invito, prontamente accettato, del
ministro della
marina
dell’epoca,
Marconi,
compiute alcune
dimostrazioni a
Roma, alla
presenza delle
maggiori
autorità, era
arrivato alla
Spezia nei primi
giorni di
luglio,
prendendo
alloggio, se non
erro, all’hotel
« Croce di Malta
», è valendosi
della
collaborazione
dell’elettricista
capo della
marina professor
Pasqualini, uno
dei fondatori
dell’elettrotecnica
in Italia,
aveva provveduto
all’impianto di
trasmissione a
San Bartolomeo.
Una prima
dimostrazione
venne fatta
collocando il
ricevitore
completo di
macchina
scrivente Morse
nei locali del
comando in capo
(allora sulla
piazzetta presso
la porta
principale
dell’Arsenale) e
vi assistettero
tutti gli
ufficiali.
Seguirono le
prove a bordo.
Ricordo sempre quel mattino di luglio del
lontano 1897 –
una tipica
giornata
dell’estate
soleggiata del
Golfo dei Poeti
– quando,
girovagando in
barca nelle
placide
insenature di
Porto Venere,
insieme al
professore
Camillo Manfroni
(l’illustre
storico delle
marinerie
medioevali di
origine
portovenerese)
vedemmo spuntare
dal Cavo un
piccolo
rimorchiatore
della marina il
cui albero era
stato allungato
in modo
inconsueto.
Procedeva a
piccolo moto,
attardandosi
lungo le allora
romantiche
calette non
ancora manomesse
dalla modernità,
fino a giungere
all’imboccatura
del piccolo
stretto e
sostare un po’ a
lungo davanti
alle case ed
agli approdi
dello storico
borgo.
Potemmo così esaminare a nostro agio la
strana
attrezzatura
della navicella
di Marconi e più
che tutto
cercare e
riconoscere
l’inconfondibile
figura del
giovane
inventore — già
riprodotta e
resa popolare in
vari giornali
dei tempo — nel
gruppetto di
ufficiali di
marina in divisa
bianca e di
tecnici borghesi
che lo
assistevano,
quali delegati
governativi,
controllando il
funzionamento
degli apparati
sistemati in
coperta, sotto
il tendaletto di
poppa.
Non è più il caso di parlare dei risultati
ottenuti in
quella prima
esperienza del
telegrafo
Marconi su
natante, che
furono
importanti, ed
ognuno può
trovare nella
letteratura
tecnica che ne
tratta. Fra
l’altro, si
constatò per la
prima volta
l’effetto
dannoso delle
«scariche» sulla
ricezione (vi
erano dense nubi
di calore sulle
Apuane) e quello
di schermo,
causante
indebolimento
dei segnali
prodotto da
vicine alture
interposte sul
percorso delle
onde. Completato
il programma di
prove sul
rimorchiatore si
volle
sperimentare la
ricezione
nell’ambiente
interno di una
corazzata —
ritenuto allora
più difficile
per le molte
cause di
disturbo e la
presenza di
macchinari
elettrici e
grandi masse
ferrose
producenti
assorbimento
della
debolissima
energia
intrinseca delle
onde impiegate.
Fu scelto all’uopo un vecchio guardacoste
adibito a scuola
nel golfo, il
San Martino,
che dava anche
la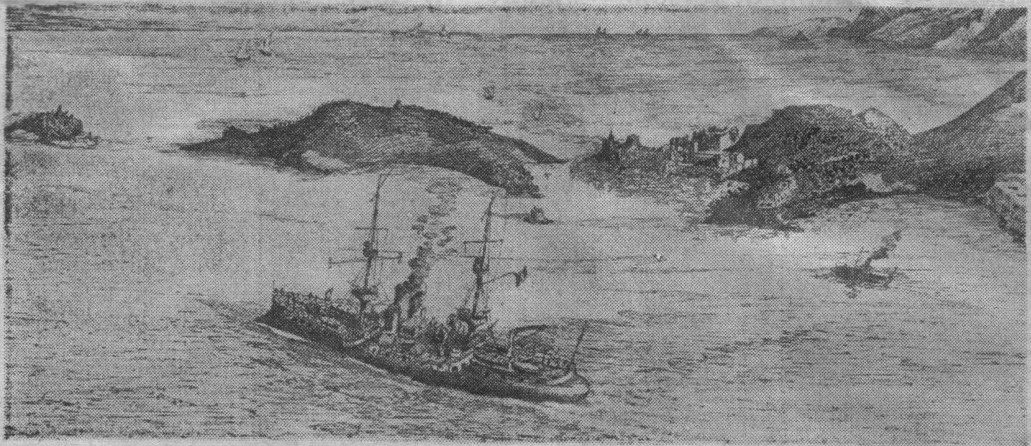 possibilità
di sistemare
meglio ed a
maggiore altezza
l’antenna
ricevente. La
prova definitiva
fu quella del 18
luglio al largo
dell’isola del
Tino, facendo
compiere alla
nave rotte in
varie direzioni.
Fra le varie
constatazioni
fatte dalla
commissione vi
fu quella di
capitale
importanza, che
l’ambiente di
una grande nave
si prestava
ottimamente alla
ricezione delle
onde elettriche
e che il
funzionamento
degli apparati
si manteneva
regolare anche
nei ponti
inferiori e
nello stesso
ridotto
corazzato. Quel
giorno la
telegrafia di
Marconi segnò
«record» di
portata: venti
chilometri
circa! Ma – quel
che più conta –
era entrata
sulle navi, al
servizio di chi
va per mare. possibilità
di sistemare
meglio ed a
maggiore altezza
l’antenna
ricevente. La
prova definitiva
fu quella del 18
luglio al largo
dell’isola del
Tino, facendo
compiere alla
nave rotte in
varie direzioni.
Fra le varie
constatazioni
fatte dalla
commissione vi
fu quella di
capitale
importanza, che
l’ambiente di
una grande nave
si prestava
ottimamente alla
ricezione delle
onde elettriche
e che il
funzionamento
degli apparati
si manteneva
regolare anche
nei ponti
inferiori e
nello stesso
ridotto
corazzato. Quel
giorno la
telegrafia di
Marconi segnò
«record» di
portata: venti
chilometri
circa! Ma – quel
che più conta –
era entrata
sulle navi, al
servizio di chi
va per mare.
L’isolamento dei naviganti era durato molti
secoli,
diventando
completo ed
assoluto dopo
l’apertura delle
nuove vie
oceaniche alla
navigazione per
merito di
Colombo. Fu
rotto
definitivamente
il 18 luglio
1897 nelle acque
del golfo della
Spezia.
|
|

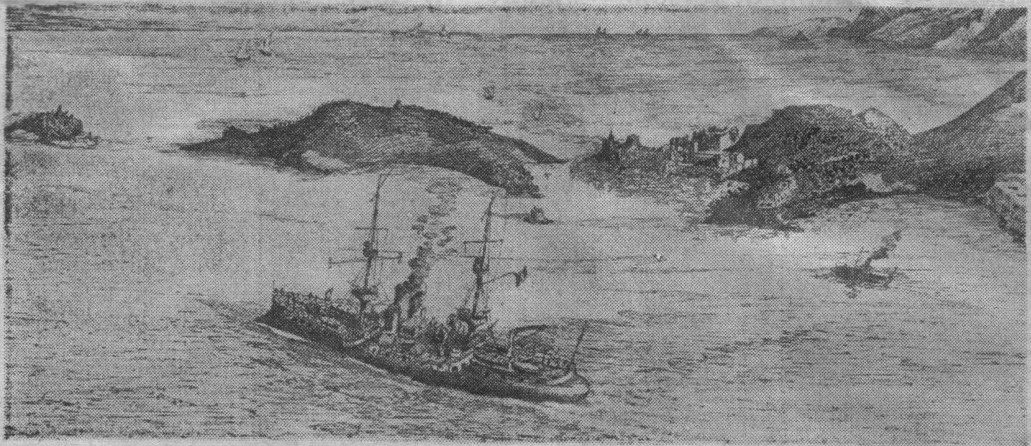 possibilità
di sistemare
meglio ed a
maggiore altezza
l’antenna
ricevente. La
prova definitiva
fu quella del 18
luglio al largo
dell’isola del
Tino, facendo
compiere alla
nave rotte in
varie direzioni.
Fra le varie
constatazioni
fatte dalla
commissione vi
fu quella di
capitale
importanza, che
l’ambiente di
una grande nave
si prestava
ottimamente alla
ricezione delle
onde elettriche
e che il
funzionamento
degli apparati
si manteneva
regolare anche
nei ponti
inferiori e
nello stesso
ridotto
corazzato. Quel
giorno la
telegrafia di
Marconi segnò
«record» di
portata: venti
chilometri
circa! Ma – quel
che più conta –
era entrata
sulle navi, al
servizio di chi
va per mare.
possibilità
di sistemare
meglio ed a
maggiore altezza
l’antenna
ricevente. La
prova definitiva
fu quella del 18
luglio al largo
dell’isola del
Tino, facendo
compiere alla
nave rotte in
varie direzioni.
Fra le varie
constatazioni
fatte dalla
commissione vi
fu quella di
capitale
importanza, che
l’ambiente di
una grande nave
si prestava
ottimamente alla
ricezione delle
onde elettriche
e che il
funzionamento
degli apparati
si manteneva
regolare anche
nei ponti
inferiori e
nello stesso
ridotto
corazzato. Quel
giorno la
telegrafia di
Marconi segnò
«record» di
portata: venti
chilometri
circa! Ma – quel
che più conta –
era entrata
sulle navi, al
servizio di chi
va per mare.